Guerra e dopoguerra - ANArtI Firenze



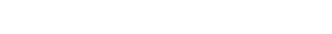
Menu principale:
Guerra e dopoguerra
Anche noi, pei quattro anni di guerra, siamo stati militari e combattenti al fronte.
Spirito vecchio e novissimo era in noi, come da queste confessioni apparirà, le quali rimonteranno perciò a quando la guerra scoppiò.
Eravamo in quel tempo molto giovani e s’andava ancora a scuola ad imparare il mestiere (il mestiere che le nostre famiglie ci mandavano ad imparare non era quello dello scrivere) e mentre a tutti i giovani sonavano nelle orecchie le fanfare, noi ci tenemmo in cuore un palpito ch’era come un verzicar primaverile e non uscimmo in alcuna baldanzosa espressione: solamente gli occhi umidi come gemme testimoniavano sul volto allora pallidetto che nella fioritura noi si sarebbe stati i più bei fiori di rama, e per intanto, aspettammo.
Qualcuno decise anche per noi, e la guerra dichiarata ebbe le coorti de’ garibaldini e de’ volontari: erano costoro nostri compagni che partivano impazientemente per 1a guerra mentre noi si restava inchiodati in casa nostra, co’ gomiti sulla tavola. Pareva anche che nessuno ci potesse strappare dagli sguardi di nostra madre, ed in quei giorni, nelle stanze uggiose, nessuno osava chiamare a nome la patria che per le piazze e le vie era invece chiamata a gran voce.
Eppure, uno dopo l’altro, con le nostre classi, ci lasciammo chiamare e l’ora della partenza, l’ora del ritorno, ordinatamente volsero.
Egualmente poteva volger l’ora della morte ed il nostro corpo rimaner tra quelli de’ compagni sepolti, sotto la croce.
Invece la Provvidenza ci ha ricondotti a bussare alla porta di casa, dove ci riconoscono alla voce la mamma e le sorelle, e, in sei, non riescono a levare il paletto, eppoi a rifarci il letto nuovo.
Eppoi se mi dici, Celeste, quello che io ti vorrei dire: che ogni notte si risogna piangendo: E cioè quante volte siamo ritornati a cercarci sul monte dove, tutto essendovi intatto, non c’è più uomo che si muova; anche qui sui rovesci tutto è muto e fermo, ed anche il cielo non ha mutamenti; non passa per l’aria una voce, né rumore vi si spande.
Ma noi si ritrovano l’orme, o come una conversazione avviata, e dagli occhi sgorgano due fonti di lacrime che si tolgono dall’anima con un gran peso.
Tutte le notti l’ho risalito quel monte, trovandolo sempre lo stesso, ma non più quello d’allora; tutto mondato di dolore, non v’alberga che una gran pace e un gran conforto.
Ma perché vi pianga tanto io non so, ma è per una gran gioia che mi vien di sotterra.
A camminarlo, a camminarlo intorno, non si ristà di piangere silenziosamente e s’insegna colle mani quello che c’è passato.
Sono cose che non si toglieran più di memoria, tu ripeti dietro il solco indirizzandoti, poi giunto al fine ti rivolti, parendoti mirabile vedermi tutt’ora buttato sull’erba, a ripensar cose di guerra, al sole del tuo campo.
Ricordo gli anni della mia vita pisana. All’armistizio un provvedimento, come si diceva, in favore degli studenti, riempì la città insabbiata di circa ottocento giovani goliardi. Si credeva che alla gioventù di ritorno, dopo lo scampato pericolo, l’allegria della vita studentesca, dovesse produrre chi sa quali benefici effetti. Invece la radunata degli ufficiali presso le università fu una delle tristezze più gravi del dopoguerra.
Maggiori, capitani, tenenti, aspiranti, tornavano nelle città universitarie sotto la comune denominazione di studenti, col berretto goliardico sull’elmetto. e gli oggettucci simbolici accanto ai nastrini delle campagne e agli scudetti delle mutilazioni.
Ma il lievito studentesco, che mescolato nell’esercito, aveva dato i suoi buoni effetti durante la guerra, rammucchiato di nuovo, dava i fortori di un’acidità insopportabile. Nelle città quiete e avvezze alle gazzarre studentesche, si prese, senza volerlo, il fare tra il soldato venturiero e il goliardo pretensioso.
Per studenti si era troppo soldati, e per soldati si era troppo studenti. I racconti delle imprese goliardiche di prima della guerra (quando fu messa la tuba d’oro, insegna di un cappellaio, alla statua del Cavallotti; quando furon mutati i cartelli, e la mattina i dottori si trovaron sull’uscio quelli dei macellari e gli avvocati quelli dei fornai) ci parevano scialbi come certi ritratti di nonni. Le nostre baldorie non erano né le allegre serate di gala, né le feroci notti di San Martino e di Santa Barbara, che al fronte si festeggiavano con scherzi più paurosi di una ricognizione. Non si sapeva più né ridere né sorridere.
Per la gelosia di una ragazza si metteva la mano alla Glisenti, e le discussioni finivano sempre con le voci aspre di comando: «Basta, silenzio, gira sui talloni!».
E non sarebbe stato nulla, se a queste apparenze non avesse corrisposto internamente un senso di vuoto, di scoramento, di disagio e di sfiducia.
La città, dal canto suo, pareva fatta a posta per farci disperare.
Quei suoi lungarni tiepidi e curvi, come accoglievano la nostra malinconia! C’era sempre una carezza di sole anche nell’inverno per chi stava coi gomiti sui parapetti di pietra lorenese tonda e morbida come un guanciale. E quel noioso balocco architettonico di Santa Maria della Spina, sceso nel greto a rispecchiare i suoi ninnoli di marmo, come tirava le nostre gotiche simpatie per l’accidiosa nostalgia!
E il violaceo tappeto attorno al Duomo, dove si estenuavano i tramonti che venivano, lunghissimi, dal mare. E le strade dritte di San Rossore, con l’acqua putrida nei fossi verdi. E le strade bianche coi tronchi chiari e scortecciati degli ippocastani. E le chiese coi campanili pendenti e le facciate oblique per il terreno molliccio e biascicato dai lombrichi!
Si pativa per la prima volta la più vergognosa virtù dei decaduti: la nostalgia. E si rimpiangevano i grandi cieli alpini gonfi di nuvole eroiche, l’incanto fiabesco delle notti passate all’addiaccio tra luminarie di razzi e rombi di cannone, la freschezza delle albe con un velo di nebbia che bagnava le ciglia, lo stupore di quei tramonti rapidi e coloriti ai quali si succedeva la notte misteriosa, piena di suoni, di agguati, di segni. Si rimpiangeva la vita nelle tane e nelle baracche, con gli uomini resi buoni dalla più cattiva calamità della terra.
Ora invece si viveva in camere ammobiliate.
A mangiare si andava nella trattoria Tripoli, dove non s’era che noi ufficiali. «Tripoli bel suol d’amore », si canticchiava avviandoci; ma appena passata la vetrina ci passava la voglia e l’allegria. Quella trattoria non era né mensa né gargotta. Mi dava ai nervi il vociare de’ compagni e il gettito delle pallottole di pane, come non potevo sopportare il motteggio continuo del cameriere guercio, con lo sparato bianco e la cravatta. Mi ritornava il ricordo di Celestino, l’attendente che, mentre mangiavo nello scaldapranzo, s’accoccolava per terra e mi raccontava le storie aretine. La tovaglia macchiata e unta mi ripugnava e avrei preferito rimangiar sulle ginocchia o sui teli di tenda, con le mani terrose.
Non ero solo a soffrire queste paturne; quasi tutti’ tolti forse coloro che avevano fatto prima della guerra per diversi anni quella vita, sentivano l’avvilimento del loro ritorno. Nel cortile della Sapienza si era una mandria indifferente.
Qualche borghese che s’arrapinava per il trenta e la lode, era guardato come un essere disumano. Per quale ragione dunque avevamo fatto ritorno tra quei colonnati? Per una laurea? E poi? Per un impiego, un ufficio, uno studio? Non era possibile.
Ricordo di aver passato in quello stato di abulia la settimana rossa, consegnato in una caserma con tutti gli ottocento compagni. Disgusto. Ricordo di aver assistito da una finestra al saccheggio di una profumeria. Indifferenza. Qualcuno dei compagni più vili, con la voce tremante, mi disse che i comunisti volevano mandarci tutti a zappare. Che gioia. Allora mi sentivo anch’io comunista!
Molta gioventù era in questo stato di scontentezza e di disorientamento, incapace di guidarsi, di governarsi e di reggersi, quando cominciò a circolare di nuovo qualche parola-comando, qualche parola-direzione.
Mi ricorderò sempre dei fratelli Rocchi. Tutti e due altissimi andavano a pari come due gemelli: della stessa natura, dello stesso grado, della stessa arma. Furono loro a portare nella trattoria Tripoli "Il Popolo d’Italia". Non avevo mai visto né sentito parlare di quel giornale, ma dal primo numero che vidi mi rimase impresso il formato, il carattere e l’articolo di fondo, lungo mezza, tre quarti, al massimo una colonna, e firmato Mussolini.
Chi era Mussolini? Non lo sapevo, ma, per superbia e un po’ per vergogna, non lo volevo domandare. I Rocchi mi passavano il giornale e restavano a guardarmi con le due coppie di occhi gemelli. Glielo rendevo con un’alzata di spalle. Non volevo dar ragione né a loro né allo sconosciuto Mussolini.
Uscivo dalla trattoria con un nodo alla gola. Prendevo verso San Rossore; camminavo divorato dalla malinconia finché non si destavano i grilli e le stelle. Allora mi buttavo sul fieno. Ne masticavo i fili con qualche lacrima amara. La terra rombava sotto il mio orecchio. Chiamavo i morti e rimpiangevo quelli che erano rimasti «lassù».
Quando tornavo, con qualche filo addosso, i compagni mi dicevano: «Sei stato con una ragazza a svoltolarti nel fieno!». «Almeno lui — pensavano invidiandomi — si consola col fare all’amore».
Piero Bargellini